



Cari giovini oggi finalmente ho trovato qualcosa di gustoso da pubblicare. Da qualche tempo i contenuti dell Resto del Cretino calavano in un vortice noioso ma sta mane ho trovato la biografia incompleta di Johnny Eck !!!!! , voi adesso penserete "ma chi c...o è Johnny Eck?) la risposta sale come un rutto dopo aver bevuto una coca cola, è quello della foto, è un 1/2 uomo la foto non è truccata, è nato cosi !!!! Ed è anche diventato famoso, ha fatto l'attrazione nei circhi e fiere, ha fatto l'attore, e anche il mago.
Perchè vi chiederete un "mostro" è diventato famoso, ma la risposta risorge impetuosa (Bruuut), lo sgorbio è nato in america la patria della democrazia e delle pari opportunità, dove negli anni 30 esistevano i Freaks Show spettacoli che esibivano i cosidetti fenomeni da barraconi, nient'altro che persone affette da handicap e malformazioni, che divertivano un pubblico più o meno morboso e arrichivano spietati manager.
Johnny Eck è stato tra i protagonisti del celebre film Freaks di Tod Browning, un'incursione straziante nel mondo dei circhi degli anni Trenta, che aperta parentesi io ho ricevuto in regalo il dvd dall mio amico Allessandro che se volete ve lo presto.
La biografia:
Nel 1980 due amici di Johnny Eck, Mark Feldman e Tom Fielding, fondarono la casa editrice Anaconda Press che avrebbe pubblicato un biografia di Johnny basata, solo sui suoi ricordi. Quando Feldman morì, nel 1984, il progetto rimase congelato (per sempre?). Al fallimento scamparono solo una conversazione telefonica di novanta minuti, un disegno di Robert Crumb per la copertina e un’introduzione firmata da Eck su quattro fogli dattiloscritti:
In una calda notte d’estate, un bel po’ di anni fa, si abbatté un improvviso e violentissimo temporale. Proprio in quella notte, in una stanza da letto al primo piano di una casa di mattoni rossi, si sarebbe verificato un avvenimento destinato a sconvolgere il vicinato.
Erano le dieci quando nacque il primo bambino: pesava due chili e mezzo, perfettamente normale.
Venti minuti più tardi, in quella stanza illuminata solo dai lampi e dalle luci a gas, vide la luce un altro bambino, al quale sembrava mancare più del metà del corpo. Questo bambino – completamente privo di arti e ossa al di sotto dei fianchi (un mostro?) – pesava novecento grammi.
In quegli anni i bambini nascevano in casa, con l’aiuto delle levatrici e dei vicini: insomma, erano in molti a dare il benvenuto al neonato. Quella notte mani delicate e gentili cullarono il bambino normale, mentre nessuno toccò né si avvicinò al mostro. Lo lasciarono lì, nella culla, da solo. Finché un’anziana signora – molto religiosa e caritatevole, invero – dopo essersi chinata sulla culla per abbracciare il mostro, non riuscì a trattenere un urlo: «Oddio, ma è una bambola rotta». Ecco cosa sembravo: una vecchia bambola rotta. Ero lungo meno di venticinque centimetri. La balia mi prese tra le braccia e mi avvicinò al fornello a gas per uccidermi, ma fortunatamente urtai una delle vicine che scoppiò in un altro urlo prima di crollare a terra svenuta.
Fu così che Dio decise che avrei vissuto in quella famiglia.
I miei genitori erano gentili e premurosi e la nostra affettuosa sorellina, Caroline, avrebbe fatto da maestra a noi gemelli. Imparammo entrambi a leggere e a scrivere prima dei quattro anni. Grazie a mia sorella, a cinque anni già scrivevo lettere e intrattenevo rapporti epistolari con tutta la famiglia. Un giorno, infatti, ricevemmo un grosso pacco. «Venite, ragazzi! Giochiamo ai postini» gridò Caroline. Nel pacco c’erano i materiali per costruire un ufficio postale in miniatura, con tanto di sportello girevole per i clienti, buste bianche e fogli di francobolli rossi, verdi e blu. Da allora tutta la famiglia prese a scriversi e scambiarsi lettere e cartoline.
Prima dell’invenzione della radio, non c’erano molti modi per passare il tempo. Certo i più ricchi avevano un bel grammofono a manovella o uno di quei pianoforti meccanici coi pedali e tutto il resto. Noi non avevamo niente, così imparai a intrattenere i miei famigliari. Probabilmente fu colpa di mia madre: doveva aver chiesto a Dio di rendermi in qualche modo utile alla famiglia. Così imparai a declamare sermoni agli amici dei miei genitori. Mi arrampicavo su una piccola cassa e mi scagliavo contro l’alcolismo, i peccati e il demonio. E i nostri ospiti battevano le mani estasiati. Una sera, dopo la mia predica (mia madre voleva che diventassi prete) decisi di organizzare una colletta: in tutto raccolsi sessantacinque centesimi. Mia madre tuttavia fu molto imbarazzata dalla mia trovata e pose fine alla mia carriera ecclesiastica.
A sette anni mi iscrissi a una scuola pubblica ed ebbe inizio un periodo molto triste della mia vita. I ragazzi più grandi facevano a pugni per conquistarsi "l’onore" e il "privilegio" di spingere la mia carrozzina sulle scale. Le finestre della classe vennero oscurate con dei drappi e io e Robert fummo costretti a uscire dieci minuti prima del suono della campanella, per non essere disturbati dai curiosi e dai bulli della scuola.
In una fredda giornata di dicembre, nel 1923, Robert e io fummo invitati a un spettacolo di magia che si teneva in un salone adiacente alla chiesa della nostra parrocchia. Alla nostra cara mammina bastava sentire la parola "chiesa" per scoppiare di gioia. Così anche lei si unì a noi in quel giorno cruciale. Ricordo che il pubblico era formato soprattutto da bambini poveri e da storpi, e naturalmente io non sfiguravo in nessuna delle due categorie. La mia famiglia era molto povera, io e mio fratello indossavamo abiti da quattro soldi, ma sempre puliti e stirati. Nonostante il freddo, Robert portava un vecchio paio di bermuda rattoppati, delle vecchie calze nere traforate dai buchi e dalle smagliature e un paio di scarpe da tennis da pochi centesimi. Io invece indossavo solo un vecchio maglione azzurro, con i gomiti consumati e il fondo slabbrato e scucito. Prima di entrare, nostra madre ci diede una sola raccomandazione: «Nascondetevi, non voglio che vi vedano». E aggiunse che ci avrebbe tenuto d’occhio per tutta la serata.
Ma mia madre ebbe la prima delusione quando il grande mago invitò un volontario a salire sul palco. Il suo invito fu seguito da uno scalpiccio di piedi e dallo strepitio di grucce, bastoni e stampelle: tra il pubblico non c’era nessuno che riuscisse ad alzarsi né tantomeno a salire i gradini che portavano al palco. Nessuno tranne uno spirito coraggioso: il mio fratello gemello Bob. Ci fu come un’esplosione: una fuga di gas, un vecchio radiatore. Invece era solo la voce di mia madre. Ecco Bob, proprio di fronte a lei, sul palco, illuminato dai riflettori come uno spaventapasseri trafitto dal sole.
Nonostante le urla di mia madre, lo spettacolo continuò senza interruzioni finché il mago trasformò un pezzo di carta in una tovaglia di pizzo. Il mago invitò un volontario a salire sul palco: gli avrebbe regalato la tovaglia. Ci fu di nuovo quello scalpiccio e il suono di stampelle, bastoni e grucce. E all’improvviso, veloce come una freccia, qualcuno saltò sul palco: con una mano reggeva il peso del proprio corpo mentre con l’altra accettava riconoscente il regalo. Era come se quel corpo fosse stato infilato direttamente nelle travi del palco. Strisciò sulle assi, tenendo la tovaglia arrotolata fra i denti, e superò i gradini con un balzo. Il pubblico esplose: urla, grida, applausi, un vero e proprio delirio. Era la prima volta che vedevano un mostro. La mia povera mamma intanto era svenuta.
Il mago era così sconvolto dalla mia apparizione che concluse lo spettacolo in tutta fretta e, dopo aver scoperto da mio fratello chi ero, chiese a mia madre di farmi salire di nuovo sul palco. Rimase lì a fissarmi per almeno cinque minuti, non riusciva nemmeno a parlare, quasi stesse trattenendo il fiato. Poi cominciò a farmi un sacco di complimenti, diceva che ero stato inviato da Dio, che ero una manna per la mia famiglia. Che lui mi avrebbe aperto le porte del mondo dello spettacolo. Avrei calcato i palchi di tutto il mondo. Dopo qualche mese avrei scoperto che il palco di cui parlava era solo un vecchio tappeto verde, ricoperto di fieno e segatura e che io sarei stato il giullare cencioso in un ridicolo carnevale di straccioni.
Avrei voluto una paga più alta, ma i miei genitori sottoscrissero subito il contratto per un anno. Al mago e al suo socio bastò aggiungere un zero all’Uno e una I ad Anno per incastrarmi per dieci anni. Cercai di ribellarmi, ma ero spacciato: il mago ci trascinò davanti a un giudice e fui costretto a rispettare il contratto. O così mi fecero credere.
Il mio nuovo agente (il mago) incassava fino a duecento dollari al giorno – ed era il 1924 – e a me ne dava al massimo venti alla settimana, più un dollaro d’argento di mancia di tanto in tanto. Io ero terribilmente triste non solo per la pietosa ricompensa che ricevo ogni settimana (quando lavoravamo), ma soprattutto per le menzogne del mio agente.
Già alla fine del primo anno del mio contratto decennale mi ritrovai gravemente malato: non potevo assolutamente lavorare per altri nove anni a venti dollari la settimana. I miei genitori erano molto spaventati: avevano ricevuto una lettera di minacce. I miei agenti li avrebbero querelati e si sarebbero presi la nostra casa di mattoni rossi. Ma io non volevo cedere: sarei tornato al lavoro solo dopo essere guarito. Mi ci volle un anno per riprendermi. Ero poco più che un bambino, ma il mio agente non voleva sprecare nemmeno un giorno. Credo che fosse il più grande estimatore di quel vecchio comandante russo che aveva sentenziato: «Il tempo è dalla nostra parte».
Ecco: io volevo riprendermi il mio tempo. All’epoca io e mio fratello avevamo quattordici anni e dopo aver provato il brivido del viaggio e dell’avventura non volevamo tornare alla nostra vita normale. Così comprammo "The Billboard", una rivista per la gente dello spettacolo. Spedimmo subito una lettera per chiedere consigli su come organizzare il nostro freak show personale e metterci in proprio. Tre giorni dopo ricevemmo un telegramma "Johnny e Bob Eck, Baltimore, Maryland. Raggiungeteci a Plainfield, New Jersey, settimana prossima. Firmato: Capitano John M. Sheesley".
Le lettere di minacce del nostro ex agente sembravano essersi placate e così i nostri genitori ci diedero la loro benedizione e ci lasciarono andare. Il capitano Sheesley mandò alcuni dei suoi uomini a riceverci alla stazione: ci caricarono su un furgone e ci portarono a vedere l’accampamento del circo. Il tendone era nuovo di zecca e, proprio accanto, era parcheggiata un’enorme carovana da circo, rossa con inserti dorati in stile cinese e delle ruote gigantesche, grandi come quelle di un carro armato: ci volevano quattro cavalli da tiro per muoverla.
Era uno spettacolo per tutta la famiglia, messo piedi da una vera e propria famiglia. Il capitano Sheesley non permetteva che ci si ubriacasse; non voleva bestemmie né altre idiozie durante lo spettacolo. Quando montammo il circo a Plainfield c’era una vera e propria folla di ragazzini a darci il benvenuto. Il capitano Sheesley prese da parte me e Bob, ci diede uno scappellotto sulla testa e, indicando la folla, disse: «Quelli sono i miei ragazzi. Fateli divertire». Dopo un po’ fece venire anche i miei genitori che vissero con noi per qualche mese. Quello fu il primo viaggio in treno di mio padre.
La Grande Depressione ci sorprese senza un soldo, niente, neanche il becco di un quattrino. Non avevamo nemmeno i soldi per pagare le tasse e rischiavamo di perdere la nostra bella casa di mattoni rossi. In quel periodo ricevetti una lettera, "Espresso" stampigliato sulla busta. "Per favore telefonami, dimentichiamo quello che è successo". La firma era quella del mio ex agente. Lo chiamai e lui mi disse che stava costruendo un luna park dalle parti di Hagerstown nel Maryland e che sarebbe stato felice se fossi tornato a lavorare con lui. In fondo non avevo niente da perdere e accettai il suo invito. Mi sentivo un re. Non dimenticherò mai quella settimana che trascorsi con lui: la casa di legno e il fiume che scivolava poco lontano, limpido e placido, il mormorio d’acqua in sottofondo.
Era un paradiso: ogni sera cenavo con il mio agente, che era un cuoco straordinario.
Era estate inoltrata quando ricevetti un’altra lettera dal mio ex agente. "Prepara le valige: si parte tra due settimane. Ti ho trovato un ingaggio per l’Esposizione Universale, in Canada". Ero di nuovo al settimo cielo: brutto segno.
Mio fratello e io partimmo per il Canada, dove ci sistemarono in uno spazio tutto nostro: ero una vera e propria attrazione ormai. La fortuna cominciava a essere dalla mia parte.
Durante uno spettacolo ci videro due talent scout della Metro Goldwyn Mayer. «Vi va di fare un provino?» Dovevamo saltare in un cerchio di fuoco: oltre a me e a Bob, all’audizione si presentò un topo gigantesco, venti chili almeno.
Ecco il mio momento, finalmente – pensai.
Quattro settimane dopo mi trovai a Cuvler City, in California, con il mio ex agente. Aveva sottoscritto un nuovo contratto, senza dirmi niente. Io credevo fossimo ancora legati dal nostro contratto canadese – che non era niente male: fifty-fifty, voglio dire… Invece il mio manager aveva annullato il contratto canadese e mi aveva fatto credere che i talent scout della MGM fossero agenti del Downey Brothers, un grosso circo californiano. E io c'ero cascato in pieno: e non scoprii niente finché non arrivai negli studios. I nostri provini avevano dato buoni frutti: qualche settimana più tardi avrei iniziato le riprese di Freaks, il capolavoro immortale di Tod Browning. Ma mi aspettava ancora una sorpresa dolorosa.
Tutti sanno che agenti e manager pretendono una percentuale sulla paga degli attori. Di solito varia tra il dieci e il cinquanta per cento. Ma per me fu una vera sorpresa, anzi uno shock, quando scoprii che avrei incassato solo il dieci per cento della mia paga. Tutto il resto sarebbe andato al mio agente. Dio, quanto disprezzo quell’uomo! E il peggio è che faceva finta di niente, anche se io avevo scoperto tutti i suoi giri loschi. Prima o poi mi sarei vendicato di lui. Ma intanto non mi restava che soffrire in silenzio.
Quando tornai a Baltimora, cominciai a ricevere lettere dalla troupe e dagli attori che avevano lavorato in Freaks. In una busta c’era un ritaglio di giornale con qualche notizia su Browning – il regista – e sul nuovo film dell’orrore che voleva girare. Purtroppo gli Universal Studios avevano programmi simili e produssero il film Frankenstein. Anche Browning scrisse una sceneggiatura sugli esperimenti con i corpi umani, usati per creare mostri e criminali. Bob e io interpretammo i personaggi principali: fu allora che persi completamente la coscienza di cosa fosse la paura.
Ci furono altre lettere: non della MGM, ma del mio ex agente. A quanto diceva, gli studios si erano messi in contatto con lui.
Purtroppo non avevo un telefono, ed ero costretto ad affidare i miei affari alle lettere. Non che facesse molta differenza per quelli della MGM: avevano già parlato con il mio ex manager e preferivano prendere accordi con gli agenti, piuttosto che con gli attori. Ma, finalmente, avrei avuto un’occasione per vendicarmi.
Mi ci volle un’intera settimana per inventare un piano preciso, freddo e ben calcolato. Decisi di scrivere due lettere. Una la mandai alla MGM per spiegare che non avevo né un contratto né un agente: ero io il manager di me stesso. Non ricevetti mai una risposta. Spedii la seconda lettera al mio ex manager, che si trovava a Baltimora. "Caro signor XY" gli scrissi, "dopo la mia ultima sfortunata collaborazione con Lei e dopo il successo del film Freaks, non ho nessuna intenzione di farmi ingannare ancora una volta da Lei. Se lo desidera, sono pronto a firmare un contratto con Lei di durata non superiore ai sei mesi e con una paga di seicento dollari settimanali. Oggigiorno un film medio viene girato in dodici settimane, pertanto vorrei che Lei depositasse settemiladuecento dollari su un conto fiduciario intestato a Bob e al sottoscritto. Il conto varrebbe da garanzia: quei soldi mi spettano di diritto, per evitare spiacevoli equivoci come quelli occorsi durante la nostra ultima collaborazione in California".
Avrei voluto essere nel suo ufficio quando ricevette la mia lettera. A quanto si dice, ebbe una specie di crisi di rabbia: pare che abbia fatto a pezzi l’ufficio. Niente di sorprendente: dopo qualche mese avrei scoperto che Mc Cauley aveva già preso degli accordi con la MGM, senza il mio permesso. Aveva ottenuto un contratto per me e Bob di seicento dollari alla settimana, spese e viaggi compresi (anche il biglietto Baltimora-Los Angeles e ritorno). Il mio agente era riuscito a strappare anche un bel po’ di favori per la propria famiglia: viaggio e spese pagate anche per la sua povera moglie malata, per un’amica, due domestici (solo per lui) e il fratello dell’amica. Io e Bob – gli attori – comparivamo solo alla fine del contratto. Avrei voluto portare mia madre con me. E, invece, per vendicarmi, mandai all’aria tutti i miei piani e quelli del mio agente, che moriva dalla voglia di tornare in California.
Il tempo guarisce le ferite, ma ho pianto per notti intere, e spesso sono rimasto sveglio a pensare all’eccitazione e alla meraviglia che ti prende quando reciti davanti alla cinepresa, negli spazi giganteschi degli studios. Lavorare con una troupe ti fa sentire accettato: quando fai un film, non sei più un mostro, ma parte di un gruppo. Non un freak alto un metro e mezzo, ma un superuomo in miniatura. Ti fa sentire il migliore tra tutti: ero qualcosa di speciale per il regista Browning e per il suo assistente Errol Taggart. Per spostarmi da una scena all’altra c’erano uomini robusti e muscolosi che mi portavano sulle spalle. Ma ormai è tutto finito.
Aprile, un’atmosfera tetra. La Depressione ci perseguita: in famiglia nessuno ha un lavoro. Ricevemmo due lettere con la posta del mattino. Per prima aprii quella con le brutte notizie: dovevamo vendere la nostra piccola casa di mattoni rossi, per poter pagare le tasse. Mia madre lesse la lettera e scoppiò a piangere. Anche i miei occhi si riempirono di lacrime e dissi: «Oh, no, ti prego Dio, non farci portare via la casa».
Mi asciugai le lacrime ed aprii la seconda lettera. Doveva essere un sogno: non potevo credere ai miei occhi. Robert L. Ripley mi voleva nel suo famosissimo Believe It or Not Show: avrei viaggiato per tutta l’America. Chicago, Cleveland, Dallas…











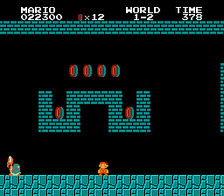




Nessun commento:
Posta un commento